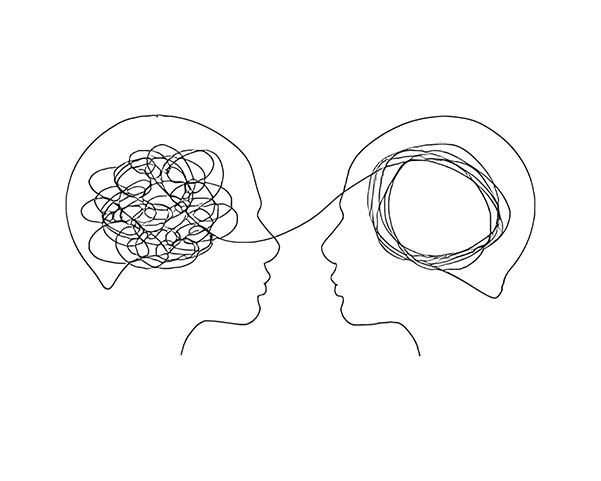
Oltre il silenzio: Il Lutto Traumatico
“Focus dei contenuti del corso: “Oltre il silenzio: comprendere e trattare i lutto traumatico”
Il viaggio del lutto non segue mai un sentiero lineare. Tutti, prima o poi, nella nostra vita ci interfacciamo con la perdita di una persona a noi cara. Il lutto può essere fisiologico, complicato o traumatico. Nel caos emotivo della perdita, il lutto traumatico, oggi è riconosciuto clinicamente come Disturbo da Lutto Prolungato (PGD) nel DSM 5 TR, per descrivere un lutto che persiste in modo intenso e debilitante oltre i 12 mesi (o 6 mesi nei bambini) dopo la perdita di una persona cara, interferendo significativamente con la vita quotidiana. È un dolore che si incunea nella vita quotidiana, che può diventare cronico, nato da eventi improvvisi e sconvolgenti, come incidenti, suicidi, omicidi, e che risuona come un’eco del disturbo dello stress post-traumatico. I ricordi restano intrappolati nella rete neurale, congelati nel tempo, e l’individuo si ritrova a rivivere ossessivamente immagini, volti e istanti di morte, attraverso flashback e sogni che lacerano il sonno.
Questo dolore non è solo psichico: diviene una ferita somatica, tensione muscolare, insonnia, ipervigilanza. La teoria dei Continuing Bonds,i legami simbolici che continuano anche dopo la perdita, ci ricorda che il legame d’amore spezzato non scompare, ma si trasforma in una presenza interiore intensa e irrisolta, che pulsa di nostalgia e struggimento.
Il Lutto nella Dimensione Evolutiva
Per i bambini e gli adolescenti, il lutto assume forme particolari, spesso silenziose, e richiede uno sguardo clinico sensibile e mirato. I bambini comprendono il lutto; ciò che sfugge loro è l’irreversibilità della perdita, ovvero potrebbero non cogliere che la morte è definitiva e che la persona defunta non tornerà. Essi non sempre possiedono le parole per narrarla e ricorrono dunque al gioco e al comportamento come strumenti primari di elaborazione emotiva. Nei loro gesti talvolta si annida la colpa, un fardello invisibile che li accompagna.
Gli adolescenti, invece, scelgono spesso la maschera: nascondono il dolore per evitare di mostrarsi vulnerabili, generando confusione negli adulti. Per questo è di vitale importanza includerli nel processo di lutto, offrendo informazioni autentiche e calibrate sulla loro maturità. Gli adulti possono concedersi di mostrarsi fragili e vulnerabili, dimostrando così a bambini e adolescenti che è normale affrontare il dolore piangendo, trasformandolo in un momento di condivisione cruciale per metabolizzare la perdita. Così il lutto diventa terreno condiviso e non un labirinto di esclusione e incomprensione.
Come trattare il lutto traumatico?
Il trattamento del lutto traumatico non si riduce a un protocollo rigido: è un’arte di integrazione terapeutica, un mosaico di approcci cuciti sul vissuto unico di ogni persona. L’evidence-based ne rappresenta il fondamento, ma è la sensibilità clinica a guidare le scelte. Gli approcci terapeutici maggiormente utilizzati nel trattamento del lutto traumatico sono:
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): scioglie l’intensità delle immagini intrusive, favorendo la rielaborazione dei ricordi congelati tramite il movimento degli occhi;
- TFCBT (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy): aiuta a riconoscere e trasformare i pensieri disfunzionali, come la colpa, e a padroneggiare le emozioni;
- ACT (Acceptance and Commitment Therapy): apre alla possibilità di accogliere il dolore come compagno silenzioso, trasformandolo in azione e significato, senza inseguire l’illusione della sua completa scomparsa.
A questi, si affiancano strumenti pratici e simbolici: il diario di lutto, la fototerapia, i riti e i gesti simbolici, come accendere una candela o creare un diario con pensieri o immagini di memorie, poiché capaci di dare forma a ciò che sembra indecifrabile. Gli approcci corporei, come lo yoga terapeutico, sciolgono le tensioni in cui il trauma si annida, restituendo spazio al respiro e al corpo.
Il Clinico e la Cura di Sé
Chi accompagna il lutto traumatico di un paziente avverte subito il peso di quella storia. Le parole e le immagini della perdita scuotono corde profonde, evocando tristezza, paura o senso di impotenza. Con il tempo, l’esposizione continua può sfociare in compassion fatigue, stanchezza emotiva, rischio di burnout o talvolta può renderlo cinico. Il clinico deve accettare, che non si può stare a contatto con la vita e la morte senza esserne toccati profondamente, e validare questa esperienza è fondamentale per gestirla in modo sano.
Per restare presenti senza esserne travolti, il professionista deve imparare l’arte della cura di sé: ritagliarsi momenti di decompressione, cercare supervisione e accettare i propri limiti. In questo spazio di consapevolezza, tra fatica e resilienza, può germogliare anche una forma di crescita interiore. L’impatto psicologico del lavoro di cura è profondo e ha molte sfaccettature: tocca pensieri, emozioni e la storia personale del terapeuta (è molto probabile che anche quest’ultimo abbia avuto un’esperienza diretta del lutto), ed emerge che la cura di sé è il fondamento della capacità di curare l’altro in modo efficace.
Inoltre, la supervisione e il supporto tra colleghi sono strumenti professionali importanti, così come lo stetoscopio per il medico, e permettono di mantenere lucidità senza farsi distruggere dal dolore provato dai pazienti. Investire sulla cura di chi cura è etico.
In conclusione, ogni persona ha il proprio modo di affrontare la perdita. Alcuni hanno bisogno di parlare molto, altri di tacere. Alcuni trovano conforto nella religione o nella comunità, altri ancora nella solitudine. Ciò non significa che il dolore sparisca, ma che trova nuove forme di espressione. Il compito dei professionisti non è quello di imporre un percorso, ma accompagnare ciò che la persona sceglie.
Non basta parlare di tempo che guarisce il dolore, poiché serve comprensione, ascolto, sostegno e, in molti casi, un intervento professionale mirato. Solo in quest’ottica, i sopravvissuti possono trovare un nuovo equilibrio, portando con sé il dolore, ma anche la possibilità di continuare a vivere.
Scritto da Sebastianelli Helena
Ambiti d'intervento
- Disturbi dell'adulto
- Ansia
- Disturbi psicosomatici
- Nevrosi
- Problemi della coppia
- Separazioni
- Problemi sessuali
- Disturbi della comunicazione
- Conflittualità familiari
- Rapporti fra generazioni
- Problematiche genitoriali
- Psicologia delle Migrazioni
- Mediazione culturale